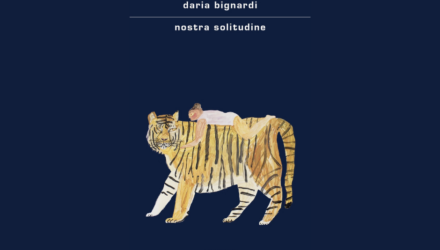di Marta Dore
Elisa di Leonardo Di Costanzo, in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia appena conclusa, è un film che colpisce per la sua intensità emotiva e morale. Protagonista è Elisa Zanetti (Barbara Ronchi), una giovane donna detenuta da dieci anni per aver ucciso la sorella maggiore e per averne bruciato il corpo. Si tratta di un omicidio che appare come un atto estremo e inspiegabile: a Elisa, ma anche alla giuria che l’ha condannata, a chi la conosceva prima e a chi la conosce oggi.

Da subito, il film ci mette davanti al tema della colpa non come condanna di un mostro, ma come esperienza umana da indagare. Elisa dichiara da sempre di ricordare poco o nulla di ‘quei fatti’, come se avesse innalzato un velo di silenzio tra sé e il passato. Questo silenzio diviene metafora – psicologica e visiva – della sua incapacità di guardarsi dentro.

Di Costanzo torna dentro un carcere e prosegue così il percorso iniziato in Ariaferma, che aveva vinto due David di Donatello nel 2022. Il penitenziario in cui la donna è detenuta, però, non è un luogo chiuso e costantemente sorvegliato come il classico panottico dove era ambientato il film con Toni Servillo e Silvio Orlando. Si trova invece dentro a uno spazio aperto sulle montagne, dove le detenute vivono a coppie in casupole nei boschi ed entro il quale sono libere di muoversi.

In un contesto così sperimentale, Elisa ha la possibilità di partecipare a una ricerca sulla violenza familiare condotta da un criminologo, Alaoui (Roschdy Zem). Gli incontri con lui sono il centro del racconto filmico: attraverso dialoghi tesi e profondi, emergono memorie dolorose e la presa di coscienza della propria colpa. Una colpa che non cerca attenuanti, ma che si carica di responsabilità: Elisa realizza che ha ucciso la sorella non per un atto istintivo o un disturbo mentale, bensì per una scelta resa possibile da dinamiche interiori oppressive e da un contesto familiare che l’ha schiacciata.
In questo percorso, la parola diventa lo strumento principale. Elisa è infatti un film di parola – in alcuni momenti ce ne sono fin troppe – non solo perché è molto parlato, ma perché mette al centro il potere del linguaggio come veicolo di scavo interiore. Nei dialoghi con il criminologo, la parola si trasforma in atto performativo: permette alla protagonista di rimettere in ordine i ricordi, di nominare ciò che ha commesso (non più ‘quei fatti’, ma l’omicidio), la propria rabbia ma anche le proprie paure; di avvicinarsi, a poco a poco, a una verità interiore che non può più essere taciuta. Il linguaggio diventa terapia e condanna, cura e ferita, dimostrando come il percorso verso l’assunzione di responsabilità non possa prescindere dall’atto del dire. In questo senso, il film dimostra quanto il silenzio possa essere distruttivo e quanto invece la parola – condivisa, ascoltata, scambiata, detta o scritta – possa aprire spiragli di consapevolezza. Di Costanzo, sulla scia studi dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali che da anni conducono ricerche sull’agire violento e sugli autori di crimini efferati, scende dentro l’animo di chi ha compiuto il male, non per giustificare, ma per comprendere.

Lo sguardo cinematografico è sobrio, quasi documentaristico: la cinepresa osserva Elisa senza giudizio, lasciando a chi osserva il compito etico di scegliere il punto di vista tra rigido rifiuto e apertura all’ascolto.
Emerge in modo molto potente anche la tensione tra responsabilità e perdono: sul fronte della protagonista, c’è un desiderio disperato di affrontare la ragione del proprio gesto e di assumersi la propria colpa come condizione da cui ripartire, non da cui fuggire. Dall’altra parte, ci sono due figure: quella del papà di Elisa (Diego Ribon) e quella della madre di un ragazzo pestato a morte da un gruppo di sbandati. Il primo, padre della vittima ma anche della sua carnefice, non abbandona questa figlia che ha ucciso la sorella, la va a trovare regolarmente e si preoccupa del suo benessere mentale; la seconda (Valeria Golino) segue le lezioni del criminologo Aloui, ma non riesce a perdonare. Si rifiuta di farlo e Di Costanzo non la giudica. Il valore del film è che non propone soluzioni consolatorie: inquadra la fragilità della possibilità di perdono, mostrandone le falle e le perplessità profonde.
Barbara Ronchi offre una prova straordinaria, restituendo un personaggio segnato insieme dal dolore e dalla freddezza. Come lei stessa sottolinea, la colpa “non si giudica, resta per sempre” – e l’unico cammino possibile è quello dell’accettazione, non della redenzione come catarsi.
Visivamente, il paesaggio alpino – freddo, isolato, imponente – suggerisce introspezione e solitudine: un luogo mentale prima ancora che geografico. L’ambientazione, come la scrittura e la regia, amplifica la densità emotiva del racconto.
Un’ultima notazione. C’è un uso estremamente molto ridotto della musica ed è una scelta che paga, perché mantiene il film lontanissimo dal melodramma.