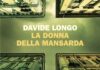di Noemi Stucchi
Francesco Piccolo esplora tematiche legate alla politica e alla società contemporanea alternando aneddoti e racconti di una biografia personale. In un racconto di formazione dallo stile ironico e diretto, nasce il libro vincitore Premio Strega del 2014: Il desiderio di essere come TUTTI.
Spiegando il titolo del libro, questo “Tutti” assume una connotazione politica e personale. Infatti:
“TUTTI è l’enorme titolo rosso che l’Unità dedica ai funerali in piazza San Giovanni; (…)”
Siamo al funerale di Enrico Berlinguer e la folla fa parte di un tutti unito. L’autore non è nel corteo, ma a casa seduto sulla poltrona davanti alla tv e dice:
“(..) Io lo saluto da casa dicendo con disperazione che ci sono anch’io, che anch’io sono parte di TUTTI” (p.138)
Quel TUTTI, grande, in stampatello, si contrappone ad un’affermazione lapidaria, tratta dal film La terrazza di Ettore Scola con Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli. Il film citato nel libro qualche pagina prima viene ripreso di nuovo a pag. 137:
“(…) Non volevo andare in un posto triste per sentirmi più triste ancora”
“E che c’era di male a sentirsi più triste?”
“Tanto il Presidente non può resuscitare. E la cosa non è successa a te. Tutto quello che succede nel mondo non succede a te personalmente”.
Il titolo del libro racchiude la tensione costante del protagonista: la voglia di appartenere, di sentirsi parte di un tutto. Questa consapevolezza si manifesta già all’inizio del libro. Da giovane aveva scavalcato i cancelli della Reggia di Caserta e prima di raggiungere gli altri decide di restare da solo, un attimo, a guardare la fontana. Come se la bellezza e la maestosità del silenzio di quel luogo potessero rivelare in un attimo un frammento della Storia con la lettera maiuscola. In un momento di rivelazione, si rende conto di essere dentro a qualcosa di più grande, come parte di un tutto. Qui ci sono io, qui inizia il noi.
Il racconto si muove tra il privato e il politico, tra l’intimo e il collettivo. Le due donne che segnano la sua vita, Elena e Chesaramai, rappresentano perfettamente questa dualità. Elena è la purezza dell’ideale politico. Chesaramai, invece, incarna la leggerezza necessaria alla sopravvivenza, quel disincanto che permette di andare avanti nonostante le delusioni.
Gli anni Settanta fanno da sfondo alla prima parte del libro, segnata dall’impegno politico e dalla tragedia delle Brigate Rosse e della fine di Aldo Moro. Queste sono forse le pagine centrali più significative: l’analisi dell’accaduto, delle comunicazioni e delle lettere scambiate con Cossiga tra ciò che doveva restare privato e ciò che è stato diffuso, romperanno quella linea di demarcazione tra l’uomo dietro al leader politico, tra figura pubblica e privata.
Il dibattito si concentra su cosa fosse giusto rendere noto e cosa invece dovesse restare riservato. Da un lato la preoccupazione di un uomo che vuole tornare a casa e dall’altro la credibilità del leader della Democrazia Cristiana. Poi la morte di Enrico Berlinguer, che segna la fine della purezza di un ideale e l’inizio del compromesso storico. Il linguaggio del privato e del pubblico si mescola, portando il protagonista a interrogarsi su cosa significhi davvero appartenere a un’idea. Soprattutto, quello che si chiederà nel corso della storia è: è giusto essere felici quando tutti non lo sono? La felicità personale può prevalere sulla giustizia collettiva?
La seconda parte del libro, “La vita impura: io e Berlusconi”, segna il passaggio dalla purezza all’accettazione delle contraddizioni del mondo reale. Il racconto si apre ancora una volta alla Reggia di Caserta, con una frase pronunciata dal Premier in carica davanti alla stessa fontana con le statue di Diana e Atteone trasformato in un cervo. Un cervo incapace di parlare e di raccontare al mondo ciò che aveva visto.
Al centro del libro c’è anche il conflitto tra il bene e il male. Si può essere felici lo stesso, nonostante tutto? Che ruolo ricopre la superficialità?
Il desiderio di essere come tutti ci conduce in un viaggio che è un punto di incontro tra intimo e universale, prese di posizione e sviluppo di un senso civico in relazione ai grandi eventi della storia politica che attraversa l’Italia dagli anni Settanta fino ai giorni nostri.
Il tutto condito da racconti sul colera e su Sophia Loren dietro alle sbarre, così come si parla di quel gol di Sparwasser dei Campionati del Mondo di calcio del 1974.