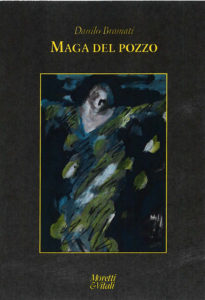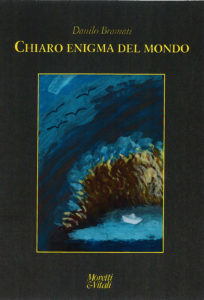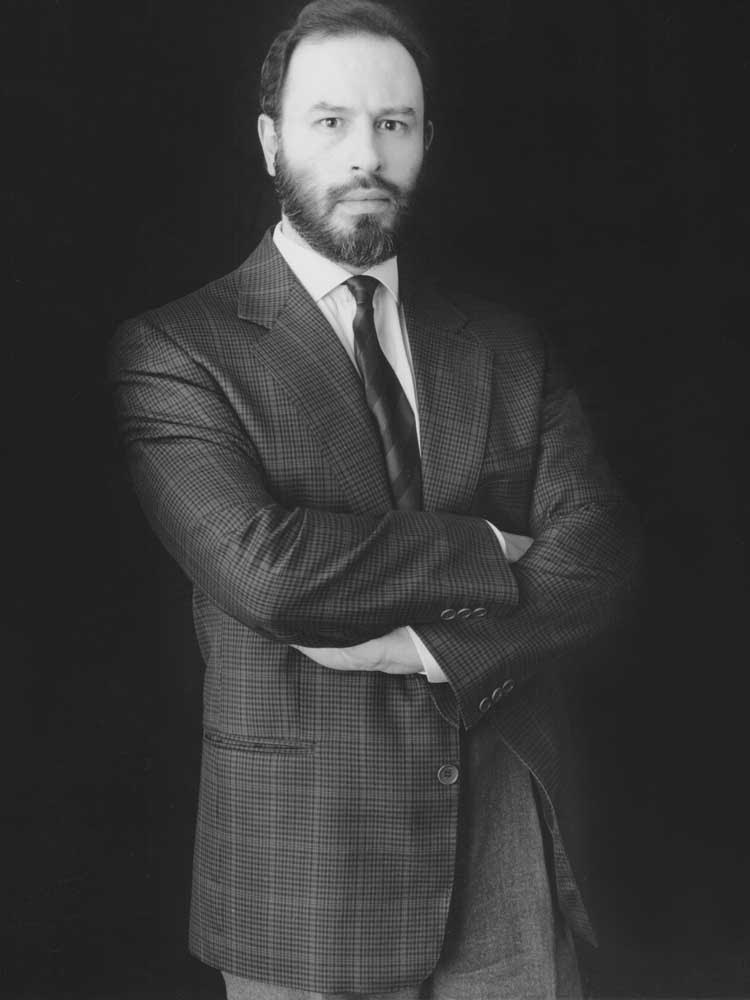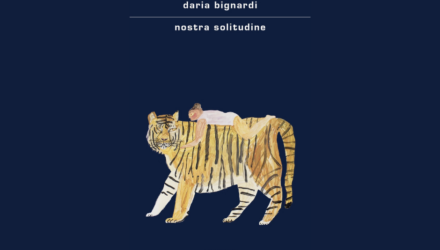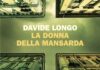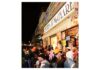di Cristina Ruffoni
“…Cosi’ il diritto si rovescia, il rovescio si raddrizza, il bene e il male si scambiano verso. Impara la lezione, devi cercare il rovescio delle cose: nel paesaggio, nel profilo delle nuvole, nei pensieri degli altri, nei tuoi pensieri…”
Il mondo rovesciato – Danilo Bramati
“Nella lotta tra te e il mondo vedi di secondare il mondo.” Quando Kafka scrive questa frase nei suoi Diari, l’8 dicembre 1917, sembra riferirsi all’eterna battaglia che il poeta Danilo Bramati sembra ingaggiare, per trovare la giusta distanza dagli esseri e le cose, anche se consapevole che poi, questi potrebbero cessare di esistere se non venissero piu’presi in considerazione e nominati. E’ trascorso molto tempo, da quando Danilo Bramati ha pubblicato nel 1992, per Guanda, il poema Nel cuore della luce. Una vita di Van Gogh in versi, uno psico noir di parole e immagini, tagliente ed accellerato. Anni nei quali, il poeta non ha smesso di cercare le parole, anche quelle piu’ deturpate e accantonate, ma queste, nell’indicare le cose, non designano piu’ solo la loro essenza ma soprattutto la loro relazione con il mondo.
Nell’indifferenza dell’artificiale e nella sopraffazione del cinismo, e’ proprio nel disincanto e nell’instabilita’, che il poeta, rinuncia a trovare qualcosa, l’amore, la salvezza o la verita’, per esporsi all’insolito, ascoltando Baudelaire, che nei suoi Piccoli poemi in prosa, racconta della “prostituzione santa dell’anima che si da’ intiera, poesia e carita’, all’imprevisto che appare, all’ignoto che passa” ed e’ cosi’ che Bramati trova un altro mondo, un immaginario paese, una nuova lingua, come nella commedia: La nostra casa (onirofarsa), nel corso della quale, questa volta, grazie anche alla comicita’ e al grottesco, convivono visione e illusione, mistero e interpretazione, salvezza e desolazione, nel recupero inebriante della memoria, nei frammenti luminosi dei ricordi.
Polvere, vento, orme, tracce. Spunta il fiore dell’assenza…Bramati si trova concorde con Heidegger che “il linguaggio e’ la casa dell’essere” e che “non c’e’ cosa dove la parola manca. Solo quando c’e’ la parola per dirla, la cosa c’e’…”. Certamente Danilo Bramati riconosce questo immenso potere alla parola ma ribadisce che a noi mortali e’ dato il frammento, quando scrive: “E dentro, dentro – cosa rimane? Poche sillabe, frasi fluttuanti.”
“Nella parola l’io si disfa, diventa bosco, strada, folla, certe volte solitudine…Quando questo succede, e resta scritto, ecco – la pagina e’ compiuta!”. Questa capacita’ di Danilo Bramati di nominare l’assente, di convivere da sempre e dar forma alle ombre, fa di ogni parola un rinvio alla totalita’, non intesa come dominio o appartenenza ma alla capacita’ della parola di aprirsi al tutto, un’apertura che si manifesta e si rivolge non piu’ all’originario manifestarsi delle cose, ma al corretto rapportarsi dell’uomo alle cose, la corrispondenza della visione umana, descritta da Heiddeger.
“E in quel non essere tu esisti.” E il ritmo della poesia di Bramati, si sintonizza ora con il silenzio, con quel “mezzogiorno” di cui parla Nietzsche, che toglie spessore alle cose, incominciando dalla loro ombra.
Per Benjamin, il Flâneur baudelairiano, significa accondiscendere al mondo senza toccarlo, inscriversi nel mondo con lo stesso gesto con cui lo si rifiuta. E nella convinzione, che scrivere non sia una missione eroica, ma piuttosto l’occasione di inventare nuove forme di soggettivita’ invisivili e sublimi, Danilo Bramati ci riconduce alla liberta’ di affabulazione creativa e di nomadismo esistenziale, quando attualmente, sembra non esserci altro che spettacolo.
Nella fiaba drammatica: Il mito rovesciato, Sironi incontra le ombre e Nel cuore della luce. Una vita di Van Gogh in versi, ti confronti con l’arte. Quale rapporto s’instaura tra le immagini abbaglianti e cariche d’ombre e le tue parole fradice, smarrite ma che fanno mondo? Anche l’arte attuale riesce ad ispirarti?
Ogni poeta ha un proprio “sentimento dello spazio”. Nella poesia tale sentimento resta implicito, virtuale, stemperato nella musica del verso, nelle metafore, nel discorso. Nelle arti visive invece è lì davanti, evidente, visibile, diretto. Così suppongo che ogni poeta prediliga uno o più artisti nei quali riconosce l’impronta della propria spazialità. E’ una questione di “affinità spaziale”. Per me è stato, in un certo periodo, Van Gogh, perché all’epoca in cui ho scritto il poema la mia visione della realtà era percorsa da vortici, gorghi, spirali…
Così io credo in una relazione stretta, indispensabile, fra poesia e arti visive. E non si tratta di un confronto, ma di un riconoscimento. Mi azzardo a dire che negli artisti che ama il poeta riconosce l’equivalente della propria spazialità, ne prende coscienza, la rivela.
Per quanto riguarda la pièce su Sironi, c’è un altro motivo che ha ispirato questa scelta: ho sempre preferito artisti che, pur dotati di talento, hanno incontrato ostacoli. Questa difficoltà ha spesso un impatto drammatico sulla loro opera, la pervade di un tormento più o meno sottile che mi attrae. Nel caso di Van Gogh erano ostacoli esistenziali, mentre il problema di Sironi è stato essere “dalla parte sbagliata della storia”, fatto che, se dapprima lo ha favorito, ha in seguito scontato duramente.
- MAGA DEL POZZO, Danilo Bramati, 2014, Moretti e Vitali Editore. In copertina MAGA, tecnica mista di Danilo Bramati
- CHIARO ENIGMA DEL MONDO, Danilo Bramati, Moretti e Vitai Editore, 2015. In copertina SENZA TITOLO, tecnica mista di Danilo Bramati
E’ sicuramente Blanchot a essersi spinto piu’ lontano di tutti nel tentativo di caratterizzare l’essenza dell’arte moderna come arte della scomparsa. Scrivere, sarebbe sempre un cercare la scomparsa? Rispetto al passato ti riconosci in questo processo di “neutralita’ ” in favore dell’opera, anzi della “realizzazione” che conta maggiormente rispetto al risultato, come diceva Cézanne?
Il “risultato” è qualcosa che consegno agli altri, al loro giudizio; la “realizzazione” è un’esigenza che conseguo (se la conseguo) in me. L’artista più fortunato (per es. Picasso) ottiene in vita entrambe le cose, in altri casi fra i due momenti avviene uno sfasamento. Allora un artista può cedere, rassegnarsi allo scacco, oppure, con un movimento interno di ritrazione, puntare tutto sulla realizzazione. Il che comporta uno spostamento di prospettiva perché l’altro, il tu, colui che giudica l’opera, insomma il pubblico, diventa per così dire virtuale. Il fruitore dell’opera sono, alla fine, ancora io stesso che mi giudico secondo criteri attinenti alla mi stessa interiorità. Mi ritraggo da una realtà ostile per conseguire l’opera, ma per conseguire l’opera devo ispirarmi alla realtà (e qui il caso di Cézanne, come quello di Van Gogh, è molto calzante). Ma dal momento che la realtà mi è ostile, devo crearne un’altra che sia abitabile per me. E così avvio un lavoro di “scavo” nel quale scompaio come soggetto per consegnarmi all’opera. Meno di me come soggetto resta nell’opera, più l’opera esprime se stessa.
L’ideale sarebbe, è ovvio, un buon equilibrio fra realizzazione e relazione con l’esterno: ma, si sa, è una questione di destino….
Nella Nota di lettura di La nostra casa (onirofarsa), Elena Petrassi, sottolinea come Yuri il protagonista sognatore, abbia inventato a causa di un’amnesia, una sua neo-lingua che si presta a equivoci, lapsus, proverbi e giochi di parole ed e’ cosi’ che s’innesca una comicita’, che diventa uno strumento espressivo e musicale fondamentale nella tua poetica. Nel futuro, intendi utilizzare ancora questa ironia, che molti poeti e letterati evitano e temono, come possibile rischio e fraintendimento alla loro greve e irreprensibile reputazione?
Nelle pièces teatrali ho utilizzato i meccanismi della fiaba, nel senso che i nessi di causa ed effetto sono stravolti, quando non ignorati. Questo conduce inevitabilmente al grottesco, e il grottesco ben si presta alla comicità. Ma ho sempre fatto in modo che il grottesco fosse impastato di afflato esistenziale, di pietà umana (Yuri, il protagonista de La nostra casa, è uno sfigato, un vinto, una vittima, uno che ha avuto la vita segnata da una strana patologia che lo costringe a storpiare le parole). Insomma, grottesco sì, comicità sì, ma come strumenti per fare luce sulla condizione umana.
“Ai tuoi fianchi c’e’ l’oceano….verranno momenti in cui saprai che e’ infinito e che non c’e’ niente di piu’ spaventevole dell’infinito…” Nietzsche (La gaia scienza) afferma e poi rinnega il potere di sostegno delle parole nomadi, mettendo in dubbio la possibilita’ di cura, attraverso la parola, professata da Freud e Lacan. Quando scrivi: “A volte ho pensieri di morte, a volte vivo….”, credi ancora, come uomo e come poeta, nel potere salvifico del linguaggio se non per il mondo, almeno per te?
No, non credo al potere salvifico del linguaggio. Credo invece nel suo potere immaginifico, nel potere che ha la parola poetica di farci accedere a un altro mondo, a un altro modo di pensiero, per cui è possibile smarrirsi e liberarsi per un istante dalla logica corrente. Non sto alludendo alla qualità “consolatoria” della poesia, perché la vera poesia è sempre problematica, trascina dubbi, incertezze, inquietudini… Parlo del fatto che la poesia, proprio perché è un genere essenzialmente a-logico, permette al poeta di innestare visioni che in altri contesti sarebbero fuori luogo. Ciò che altrove sarebbe fallace e contestabile, in una poesia può essere geniale, stupefacente, perché leggendo poesie è necessario sospendere la logica consueta e accogliere possibilità paradossali.
Ma alla fine il linguaggio poetico non salva niente e nessuno, quella magia si dissolverà e torneremo al mondo consueto, ai nostri soliti problemi… e lì la poesia non ci soccorrerà.
A chi vuole essere poeta, a un giovane, in un paese come l’Italia dove impera la sterilita’ del sempre uguale, come ribadisce Adorno, cosa consigli, a parte leggere, per non soccombere alla logica feroce del mercato editoriale?
I consigli sono sempre inutili, se non dannosi e fuorvianti. Il giovane poeta faccia come vuole, pensi secondo le proprie inclinazioni, accetti consigli solo quando si incontrano con la sua personale visione.
Progetti futuri? O esperienze trasversali da traduttore o scrittura di libretti per compositori o registi teatrali, che hai affrontato in passato, come nel caso della collaborazione con Marco Tutino e Giampaolo Testoni?
Non ho progetti, vivo alla giornata…
“….devi percorrere ogni attimo, ogni attimo….” Qual’e’ il ritmo interiore della tua scrittura? Quello della quotidianita’ invece, coincide in qualche modo con quello della poesia? Non e’ piu’ all’unisono ma neppure in contrasto?
Per me la scrittura ha un rapporto mediato con la realtà. La realtà che mi ispira è minimale: una foglia che cade, un’orma impressa nell’erba… Ma in ciò che scrivo questi eventi alludono sempre a una condizione esistenziale: la foglia che cade va verso il declino, l’orma nell’erba testimonia un’assenza…
In questo senso la poesia che scrivo ha un rapporto mediato con la realtà: il dato reale è filtrato attraverso un’immagine interiore che lo “distorce”, lo trasforma in segno di una condizione. L’immagine interna si sovrappone alla realtà, la volge a una “micro-narrazione” che è l’ossatura della poesia. Attorno a questa svolgo un lavoro efferato sul ritmo, sulla musica del verso. Se la poesia riesce, sarà una ritmica stranezza, perché ci tengo che l’aspetto concettuale sia soprattutto strano, straniante, insomma che induca nel lettore uno spostamento di ottica che lo sorprenda e lo disorienti. E’ questa, secondo me, la forza della poesia: il suo potere disorientante.