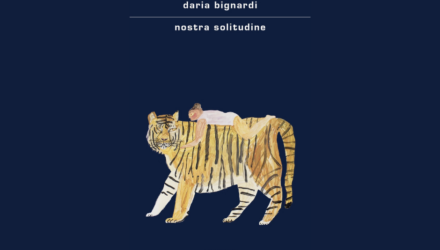di Silvia Simonetti
Qui non è Hollywood – L’Avetrana di Pippo Mezzapesa
In un borgo Salentino, Avetrana nel 2010 avvenne uno degli omicidi più importanti degli ultimi anni, laddove la giovinezza svanisce per un colpo d’invidia, gelosia insana e tradimento familiare.
La vicenda si trasforma come tutte le storie deformate, violente e con una lenta incomprensione di fronte all’animo umano ma in questo caso abbiamo una lente più portentosa, con la miniserie televisiva italiana diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Matteo Rovere, dal titolo Qui non è Hollywood in uscita su Disney+ e tratto dal libro Sarah – La ragazza di Avetrana di Flavia Picccini, Carmine Gazzanni.
Forse per la prima volta, ci troviamo un cast del tutto innovativo, attori bilanciati in ruoli reali difficilmente sostituibili come per Federica Pala in Sarah Scazzi, Giulia Perulli in Sabrina Misseri, Paolo de Vita in Michele Misseri e in Vanessa Scalera in Cosima Serrano.
Il regista pugliese entra in una fase confidenziale della storia, laddove invita gli attori a una vera celebrazione interpretativa divisa in quattro fasi della serie, in modo da ponderare una scelta cronologica temporale dell’avvenimento di Avetrana.
A partire dallo strangolamento, al ritrovamento del corpo in un pozzo d’acqua come occultamento del cadavere da parte dello Zio Michele Misseri, la gelosia adolescenziale di Sabrina nei confronti di Sarah e Cosima che difenderà sempre la figlia come unica complice.
L’inizio della serie incomincia con la figura principale di Sarah, attraverso lo sguardo innocente, ribelle dove cerca una via d’uscita per non vivere in un paesino sperduto tra le campagne.
Il regista ci fa vedere una prospettiva candida ma anche profetica, anticipa mediante luoghi, oggetti l’aspetto sensoriale del destino della ragazza, la sua fase d’innamoramento di Ivano, amico e presunto promesso di Sabrina.
Il fisico leggero e le chiome d’oro riportano a una bellezza celeste ma che conducono non solo a risentimenti ma a un vero odio, provato soltanto da chi si sente inferiore a se stesso, quanto basta per rubare solo un attimo di eterna freschezza giovanile.
Mezzapesa non ci farà mai vedere l’atto violento della morte, elegantemente non ci induce a uno sguardo comune ma vi è un immaginario della scomparsa, possiamo intuire attraverso la seconda puntata, con la presenza della cugina Sabrina, il legame familiare perché Sarah voleva avere il divertimento e la libertà che non ha mai avuto ma che riscontrò in Sabrina fino al punto di un elemento terzo: Ivano.
Quest’ultima, nota che la sua presenza viene trascurata e in qual modo rifiutata da Ivano e scatta un’imprevedibile e mortificante messa in scena, che i procuratori definirebbero: una fredda pianificazione d’una strategia finalizzata, attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e forvianti al conseguimento dell’impunità.
Oltre ad aver strumentalizzato i media portandoli a una confusione e menzogne fini a se stesse in cui ogni pettegolezzo di paese diventa verità contingente.
Mentre nel terzo episodio appare l’ipotesi del pentimento con lo zio Michele Misseri, un uomo perseguitato dal peccato, essendo religioso e legato alla natura contadina, cerca in qualche modo di far trapelare attraverso gli oggetti perduti, congetture verosimili alla realtà e con l’ammissione del ritrovamento del corpo, ovvero tramite i pozzi che rimangono simbolo rappresentativo del buio e della solitudine, ricordiamo il caso di Alfredino Rampi.
In lui vediamo una profonda fragilità, una dolorosa oppressione al contrario della figura della moglie e madre Cosima Serrano, che prevede un’interpretazione magistrale di Vanessa Scalera, perché a differenza degli altri ruoli conclude la serie con la potente e severa figura materna, che non solo disarma con la sua irremovibilità ma rimane in uno stato di conservazione, il trucco indurisce le sue parole ma è anche l’unica a riconoscere il corpo ormai trasfigurato dall’acqua imputridita dal tempo.
Sconvolgente il confronto finale tra le due madri e sorelle allo stesso tempo, il regista cura i dialoghi con una voragine scenica senza mai finire in un grottesca ignoranza visiva.
Tutto rimane cristallizzato in una memoria ceduta dall’ingiustizia e dall’altra parte la conseguenza della morte: l’ergastolo che neanche lo sconto di pena può salvare questo omicidio.
Il regista termina con un sillogismo figurativo: Cosima rivede per l’ultima volta Sarah nella casa dov’è avvenuto il delitto, uno spettro ben definito della nostalgia che irrompe per sempre il desiderio dell’espiazione.
Le dice di andarsene che non fa parte più di questa famiglia, probabilmente il senso di appartenenza non è mai esistito eppure ci alludiamo che gli affetti familiari possano esser fedeli con le nostre aspettative mentre si rivelano traditori e a volte ci rimane l’unica via alternativa: bisogna discernere, separare la radice intima di ciò che ci ha messo al mondo, di chi ha voluto crearci, senza aver avuto la libertà e il desiderio di conoscere o amare la vita, come disse Mariangela Gualtieri, Poetessa italiana nel tuo testo poetico “ Fuoco centrale”: Io non so se l’amore sia una guerra o una tregua, non se l’abbandono d’amore sia una legge che la vita cuce fino all’ultimo ricamo finale.

Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0